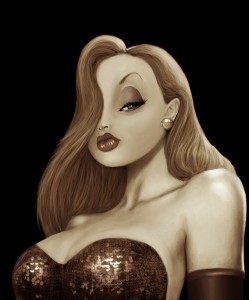 A ben vedere, il semplice fatto di scrivere un post in un blog è allineato alla logica della prestazione: se scrivo è per render pubblico un pensiero, così che qualcuno legga e si ponga in accordo, in disaccordo o faccia i suoi distinguo. Ma, a parziale discolpa, i miei lettori sono meno di quelli manzoniani. Quindi in pratica scrivo per me.
A ben vedere, il semplice fatto di scrivere un post in un blog è allineato alla logica della prestazione: se scrivo è per render pubblico un pensiero, così che qualcuno legga e si ponga in accordo, in disaccordo o faccia i suoi distinguo. Ma, a parziale discolpa, i miei lettori sono meno di quelli manzoniani. Quindi in pratica scrivo per me.
Sempre qualora si debba rilevare una colpa, un’accusa del tipo: anche tu desideri apparire. Ebbene, sì. Ma non è una colpa: sto al mondo e obbedisco al mondo finché esso non mi costringa ad andare contro me stesso.
Chiamo logica della prestazione una delle possibili linee di forza con cui cercare di spiegare quanto ci circonda. Non ha la pretesa di dire la realtà , ma di offrirne una griglia interpretativa. Giudizio riflettente, lo chiamerebbe Kant. Secondo la LdP, ciascuno di noi è invitato ad agire non con l’obiettivo dell’azione stessa, ma con l’obiettivo di essere giudicato “a posto”, accettabile, degno di riconoscimento e di fiducia. L’obiettivo dell’azione non è realizzare quanto l’azione prevede, i mezzi migliori per un dato fine, ma è spostato: si punta qui, per ottenere un là . Per esempio potrei scrivere questo post non perché ne ho bisogno, o perché voglio gettar luce su un mio garbuglio mentale, ma perché così posso venir letto, commentato. Visto. Per esempio studio non per apprendere, ma per evitare un brutto voto. Gioco a calcio non per la mia passione per questo sport, ma perché così sarò preso in considerazione per una squadra più quotata. Lavoro non per trasformare la natura (sia essa materiale come spirituale) ma per conservare il mio posto, per soddisfare un capo, per pagarmi le rate dell’auto, per mantere alto il livello della qualità materiale di vita.
Il soggetto così non è il portatore dei mezzi verso un fine, e non è nemmeno – secondo il paradigma classico, l’attore della propria realizzazione. Il soggetto agisce per essere oggetto – visto, letto, guardato, riconosciuto o solo accettato. In questo il soggetto/oggetto mette la propria realizzazione. Non mi importa se quanto scrivo è logicamente argomentato, o concerne quanto più possibile la verità dei fatti: scrivo perchè di me si parli. Studio per evitare l’ansia del brutto voto, che genera delusioni in famiglia: quindi se questo è l’obiettivo, non mi interessa che l’azione dello studiare obbedisca a se stessa, perché possono esserci altri mezzi per evitare quell’ansia. Gioco a calcio per arrivare “in alto”, ma se posso arrivarci tramite una “spintarella” il gioco, letteralmente, è fatto. Per conservare il mio posto di lavoro posso anche reperire delle scorciatoie; per soddisfare un capo posso leccargli il sedere; per guadagnare di più posso cercare espedienti sotterranei o anche illegali. Di quel che è lo scrivere, lo studiare, il giocare, il lavorare – in sé – in fondo non mi dò pensiero.
Mi si obietterà che io sottointendo il fatto che ciascuna di queste azioni abbia una propria natura, alla quale posso obbedire o, nella LdP, non farlo. E mi si chiederà di dimostrare questa presunta essenza. Rispondo che non intendo affermare che esista il “lavoro in sé”, ma che esiste qualcosa che riconosciamo collettivamente come lavoro. E questo dovrebbe avere a che fare con una passione, una serie di competenze, un problema da risolvere e la scelta dei mezzi più efficaci per farlo. E così per le altre azioni. Nulla di assoluto, ma solo il tentativo di obbedire al mondo come lo abbiamo costruito e al linguaggio che usiamo per dirlo.
L’elemento deteriore in tutto questo, è che la LdP agisce in maniera carsica. Cioè siamo convinti ad accettare questo tipo di logica come quella ovvia, naturale. Qui sta l’abisso, il fatto cioè che sia la paura il movente ultimo. Se non sei così, sei fuori. La LdP diventa drammatica quando non è oggetto di scelta, di riflessione, di deliberazione. Perché in questa maniera non saremo mai portati a confrontarci con la responsabilità della nostra azione. «Non sono cattiva, è che mi disegnano così» diceva un cartone animato.



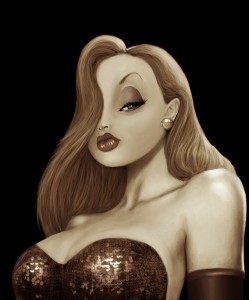 A ben vedere, il semplice fatto di scrivere un post in un blog è allineato alla logica della prestazione: se scrivo è per render pubblico un pensiero, così che qualcuno legga e si ponga in accordo, in disaccordo o faccia i suoi distinguo. Ma, a parziale discolpa, i miei lettori sono meno di quelli manzoniani. Quindi in pratica scrivo per me.
A ben vedere, il semplice fatto di scrivere un post in un blog è allineato alla logica della prestazione: se scrivo è per render pubblico un pensiero, così che qualcuno legga e si ponga in accordo, in disaccordo o faccia i suoi distinguo. Ma, a parziale discolpa, i miei lettori sono meno di quelli manzoniani. Quindi in pratica scrivo per me.

 Io proseguo col mio insegnamento nel corso di laurea in psicologia, che si avvia a diventare una Facoltà . I miei rapporti con gli studenti sono sempre stati in tutti questi anni (e del resto lo erano anche prima) molto soddisfacenti, e talvolta addirittura splendidi (anche se vi sono stati periodi in cui mi sono augurato che all’impegno individuale nello studio si accompagnasse in loro una maggiore sensibilità per i problemi generali dell’universira e della società civile e un coinvolgimento più intenso, come era successo nel ’68 e come è accaduto poi anche altre volte, con un andamento ciclico, fino al movimento recente, vivace ma effimero, della «pantera»).
Io proseguo col mio insegnamento nel corso di laurea in psicologia, che si avvia a diventare una Facoltà . I miei rapporti con gli studenti sono sempre stati in tutti questi anni (e del resto lo erano anche prima) molto soddisfacenti, e talvolta addirittura splendidi (anche se vi sono stati periodi in cui mi sono augurato che all’impegno individuale nello studio si accompagnasse in loro una maggiore sensibilità per i problemi generali dell’universira e della società civile e un coinvolgimento più intenso, come era successo nel ’68 e come è accaduto poi anche altre volte, con un andamento ciclico, fino al movimento recente, vivace ma effimero, della «pantera»).