Franco Cordero, quasi come Thomas. Cliccando sull’immagine odontoiatrica.
L’etica nel lavoro (rileggendo gli stoici)
 Leggere gli autori delle cosiddette Scuole ellenistiche rimane uno dei doveri (e piaceri) di chiunque. Ma avere la possibilità di condividere alcune intuizioni di Seneca, Marc’Aurelio ed Epicuro (in ordine sparso) con un gruppo di ragazzi, è un’esperienza appagante. Come diceva il buon Sandro Onofri, questi sono i momenti in cui ringrazio per la professione che ho scelto.
Leggere gli autori delle cosiddette Scuole ellenistiche rimane uno dei doveri (e piaceri) di chiunque. Ma avere la possibilità di condividere alcune intuizioni di Seneca, Marc’Aurelio ed Epicuro (in ordine sparso) con un gruppo di ragazzi, è un’esperienza appagante. Come diceva il buon Sandro Onofri, questi sono i momenti in cui ringrazio per la professione che ho scelto.
Il dialogo è nato a partire da una provocazione che l’imperatore filosofo riprende da Epitteto (attenzione! Si tratta davvero di un messaggio difficile da ascoltare!):
“Baciando il figlioletto bisogna aggiungere tra sé: «Domani forse morirai». «Ma sono parole di cattivo augurio». «Nessun cattivo augurio – diceva Epitteto -: indicano invece un fatto naturale; altrimenti anche la mietitura delle spighe diventa un cattivo augurio”.
L’anticipazione di un fatto che gli stoici considerano fisiologico, come la morte, avvicinabile al taglio del grano o alla vendemmia, porta il filosofo a considerare tale eventualità reale e addirittura vicina anche per il proprio pargolo. Cattivo augurio? (Diremmo oggi: vuoi portare sfiga?) Non si tratta di pronosticare la morte della persona che ci è più cara al mondo, ma se mai di considerarne appieno la vita, proprio esercitandosi al pensiero della sua conclusione.
Nella concezione stoica della cosiddetta Atarassia (lett. assenza di turbamento), che possiamo pensare anche come Indifferenza (dare alle cose l’egual peso che esse meritano nell’economia del cosmo) o Magnanimità (dilatare il proprio animo affinché possa ospitare continuamente alternative alla prima impressione o al giudizio immediato), immaginare per un padre la possibilità della morte del figlio significa esercitarsi a rinunciare al pieno controllo sulla sua vita.
In altri termini, significa avere ben chiaro che noi possiamo naturalmente desiderare la felicità di nostro figlio, ma che dobbiamo fare i conti con le nostre effettive possibilità di realizzarla. Se essa diventa una sorta di imperativo o addirittura di ossessione, probabilmente otterremo l’effetto opposto. Soffocheremo la nostra creatura con il bene che per lei desideriamo.
Lancio al gruppo di ragazzi uno spunto. Se decidessi di intraprendere un secondo lavoro per poter garantire a mia figlia un livello di vita (economicamente) superiore, sono sicuro che il tempo sottratto a lei non sia in ultima analisi più dannoso per la nostra relazione? Oppure, in altri termini, sono certo che l’esigenza economica non diventi per me una sorta di “passione triste” che si metta in mezzo tra me e lei?
A questo quesito si alzano le barriere, quasi fosse avvertito come una critica al tempo lavorativo dei genitori (formulata per di più da chi, nella vulgata, lavora mezza giornata). Ma non è così.
Incrocio allora questa possibilità con un altro elemento: nei mesi passati una studentessa chiese di poter parlare del fenomeno dei suicidi a causa della crisi e del fallimento della propria azienda. Talvolta, nelle ultime drammatiche spiegazioni del gesto, figurava la vergogna di fronte ai figli, o il timore di non poter garantire loro una vita dignitosa.
Allora, una ragazza disse una cosa che mi diede da pensare: sono grata ai miei genitori per quello che mi danno, tuttavia vorrei vivere diversamente da loro il lavoro. Come dire: è un ingrediente fondamentale dell’esistenza, ma attenzione che non invada ogni ambito dell’esistenza stessa.
Gli stoici s’intendevano di suicidio, giacché lo consideravano l’ultima spiaggia dell’uomo assennato nel momento qualora le condizioni materiali di vita non gli consentissero più di praticare la virtù. Non è quindi un suicidio cercato, come si suole dire, per disperazione e sul quale non è possibile – né corretto – esprimere alcun giudizio. Se mai, una domanda: quale visione del lavoro avevano queste persone? Quale peso ad esso attribuivano?
I ragazzi Рquesto ̬ il primo elemento fondamentale, che costituisce una conferma Рosservano continuamente gli adulti. Che lo facciano consapevolmente o meno, cercano un confronto, una pietra di paragone; misurano le azioni con le parole che i genitori o gli insegnanti pronunciano, ne verificano la coerenza o meno.
Il secondo elemento: alcuni di essi raccontano come hanno compreso quanto il lavoro sia una parte fondamentale della vita adulta e come sia necessario sacrificare il tempo passato con i figli in nome della professione. Sono anche consapevoli che questo sacrificio corrisponde al desiderio di realizzarsi pienamente come persone: non è un dramma, ma un’esperienza di creatività e di impegno personali. Emerge chiaramente come in queste famiglie accada un fecondo e continuo dialogo su quello che la vita richiede, sui patti ai quali dobbiamo scendere, ma anche sui risultati che fanno dell’esistenza un’esperienza entusiasmante.
Altri ragazzi rimangono perplessi. Sono coloro che in silenzio annuiscono quando vengono posti di fronte all’idea di come davvero qualche adulto – forse messo alle strette – abbia prediletto il lavoro (la carriera) alla famiglia. Può sembrare retorico, o cinematografico… Ma neo fatti accade. Si potrebbe dire che non si sentano scelti sino in fondo. Spesso sono i medesimi che comprendono che, qualche volta, giustificare le scelte con un “è per il tuo/vostro bene” nasconda alcune ambiguità . Non le sanno sviscerare, ma le avvertono e si ritraggono. Più di qualche volta sono coloro che faticano a trovare nella scuola un senso, una buona occasione, una sfida ottimale e si trovano piuttosto a subirla.
Ecco quindi il terzo elemento: impariamo a fare “il nostro dovere” non perché ci venga insegnato a parole. Ma perché conviviamo con persone che fanno del proprio dovere un’occasione di ricerca del senso della vita. Non l’unica, non quella esclusiva. Nel lavoro c’è un senso, ma il lavoro non coincide con il senso. Quale esso sia, nemmeno gli stoici possono rivelarcelo in maniera assoluta. Ma dal loro pensiero possiamo prima di tutto riconsiderare questa parola – dovere – spesso non amata (perché spesso imposta) e insieme lasciarci ispirare per la nostra personale ricerca di senso.
Storie da gufi
sir Ken Robinson #1.1
Agli albori del blog proposi la versione inglese (QUI).
Ora Changing Paradigm è stato tradotto in italiano:
Edit: si tratta di un contributo cha ha quasi quindici anni. Ora, non solo è ancora valido, ma è ormai acquisizione interiorizzata da parte de* student* (marzo 23)
L’incantesimo della speranza. Cit.#3

Più spesso Socrate descrive [la sua dottrina] semplicemente come un motivo di speranza. (…) O vi è una possibilità che la vita abbia un senso, oppure sarebbe meglio non esser nati. O si può sperare di là da questo mondo in una giustizia per i giusti, oppure non resta che disperarsi per un’esistenza tanto irridente da far re i giullari e tanto tragica da far acclamare dalla torma il martirio degli innocenti. Se non trovassimo una qualche ragione per poter sperare in un’altra esistenza, saremmo annientati dalle troppe occasioni d’infelicità che questo mondo ci offre. Non ci si può salvare che con la speranza, e questa speranza non può essere salvata che con la fede. Per quanto poco sia credibile, il meglio che si possa fare è sempre credervi. Se il tenue filo della logica può condurci alla minima ragione di speranza, occorre stare attenti a non romperlo, e a non permettere che alcuna riserva rimetta in discussione la ragione. Ecco perché “giova fare a se stessi di tali incantesimi” (Fedone, 114d): non bisogna smettere di credere alla ragione, se si vogliono avere motivi di speranza.
(…)
Proprio perché la nostra vita deve testimoniare il nostro pensiero, dobbiamo vivere quello che pensiamo via via che andiamo a scoprirlo. (…) Puntiamo la nostra vita su una speranza, e questa, a sua volta, su qualche associazione logica. Per aver fede in questa aspettativa, dobbiamo quindi esserne convinti, e per credervi è indispensabile identificare la nostra anima col nostro pensiero. Solo così il nostro pensiero si fa “incantesimo”, e la nostra vita testimonianza. Eccoci nuovamente di fronte ad una scelta: o il nostro linguaggio assume la funzione di evocazione e, tenendoci distanti da ciò che descrive e riporta, ascrive il nostro pensiero a oggetti che gli sono esteriori, o agisce da incantesimo e rende interiore tutto quello che enuncia: non solo crea ciò che dice, ma ci trasforma subito in ciò che crea. Attraverso una sorta di mimo interiore, ci dentifichiamo in quello che afferma il linguaggio. Non ce ne distinguiamo più: lo siamo”.
(N. Grimaldi, Socrate, lo sciamano. Il primo guaritore di anime; Asterios, Trieste 2012; pp. 92-96)
Carlo Maria Martini, Portatore di Luce
Il Cardinale (e mai come adesso ci rendiamo conto di quanto fosse capace di orientare la sensibilità e il pensiero dei cristiani ancora in ricerca) non meritava molte delle cose scritte sui quotidiani in questi giorni, che hanno riportato l’ennesimo pseudo dibattito stracolmo di ideologia, da qualsiasi parte lo si guardi.
Così, per onorarne la figura, riporto di seguito alcune parole significative, lasciate da persone molte delle quali altrettanto luminose e come lui senza fretta di abbottonare la verità addosso alle persone.
Don Angelo Casati, nel luglio del 2002, scrive questa poesia
Gli occhi sul mare
al mio vescovo
Carlo Maria Martini
E ora che il tempo
si è fatto breve
e il cuore si consuma
a trattenere la tua immagine
che sembra svanire lontano,
punto rincorso
all’orizzonte estremo,
ora che gli occhi
sono sul mare
come di chi saluta
pur se la vela è scomparsa,
come le pupille dei discepoli
perdute, sul monte,
in un cielo orfano
del volto,
ora so che anche per l’addio
di un pastore di chiese
può ferire e urgere
agli occhi la commozione
e dilatarsi
fino allo spasimare
delle vene dei polsi.
Sei scritto
come sigillo sul cuore
e sul braccio.
Hai amato queste strade
hai pianto
su questa città .
Ci lasci
-ed è testamento-
la lampada della Parola
e il pane del volto.

Giovanni Colombo, consigliere comunale a Milano, già presidente della Rosa Bianca, animatore delle riviste “Il Margine” e “Appunti di cultura e di politica”
Oggi il Cardinal Martini ha terminato la sua corsa terrena. Scompare dai nostri occhi uno dei personaggi principali della vita della chiesa nell’ ultimo trentennio, un (quasi) Papa, molto letto, molto ascoltato dai media (anche se non è mai stato, a differenza di Wojtyla, l’uomo delle folle e del gesto). Se ne va il Gigante, il principale riferimento religioso, morale, intellettuale della mia giovinezza. L’ho seguito fin dal suo arrivo in diocesi, ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e di confidarmi con Lui come fosse mio padre. A lungo mi sono vantato di essere un “martiniano”, poi ho smesso, visto che lui stesso mi ripeteva: di Maestro ce n’è uno solo!
Martini si è speso fino all’osso per farci conoscere la Parola. “In principio la Parola” è il titolo della sua più intensa lettera pastorale e ben sintetizza il cuore del suo magistero. “Leggi la Parola… sottolinea la Parola”, quante volte l’ha ripetuto. La Parola che parla di Gesù è Gesù stesso, e come lui incessantemente in moto, senza fine nel movimento di dare tutto di se stessa. Se ascoltata e “ruminata”, susciterà in noi le parole giuste per quest’ epoca di alto sbandamento, le parole gocciolanti in grado di “rimettere al mondo il mondo”. Â
Con le sue parole intorno alla Parola, Martini mi ha cambiato Dio. Non più il Dio lombardo, cupo, controriformista, il Dio col vocione che produce l’inflazione del senso di colpa. Ormai Dio è vento sottile e sua volontà la nostra liberazione: la partenza da tutti i varchi, l’apertura di tutte le gabbie. Ah, le gabbie…
In Martini ho visto da vicino la fatica di star dentro le tante costrizioni in cui s’infossa la vita della chiesa cattolica d’Occidente, sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista pastorale. Alla fatica si è presto aggiunta (metà degli anni ottanta) anche la viva preoccupazione di non apparire l’anti-Papa, l’anti-Wojtyla, e di riuscire a sottrarsi al continuo controllo vaticano. A mio avviso, era in battaglia continua, fuori e dentro di sé, con il marmo di sacra romana chiesa. Da un certo punto in poi il campo di questa battaglia è diventato il suo stesso corpo, come se il tremolio parkinsoniano non foss’altro che la costante lotta tra la spinta ad essere se stesso e la controspinta a non esserlo, per non disobbedire all’ autorità costituita. Alla fine il controllo estremo ha avuto il sopravvento e il Gigante si è trovato rinchiuso dentro una corazza. Ha dovuto rinunciare alla sua originalità , alla sua “martinità “.
E’ stato bello, sì, molto bello conoscere e frequentare padre Carlo. E il modo migliore di ricordarlo sarà quello di seguire la strada che lui stesso aveva intravisto dal suo personale monte Nebo e di cui parlò tanti anni fa durante la messia esequiale di uno dei suoi più cari amici, don Luigi Serenthà : “procedere per una più grande scioltezza nella Chiesa, per una più grande libertà di spirito, per una più grande creatività , soltanto in questo modo si manifesta la vitalità della Parola, del mistero pasquale della morte e della risurrezione di Gesù”. Aveva capito assai bene quant’ è indispensabile alleggerire e, in tal senso, è riuscito a fare più di quanto lasciasse prevedere la sua estrazione alto borghese, la sua impostazione perfetta e il suo ruolo di “principe della Chiesa”. Oggi, finalmente sciolto da pesi obblighi dolori, è giunto “nella pienezza totale che non è cancellazione delle singole individualità ma affermazione piena dell’ individualità di ciascuno in una perfetta armonia in Dio” (citazione dell’ Inno all’ universo di un altro gesuita, Teilhard de Chardin, che Martini stesso usava per spiegare come sarà in Cielo). Adesso tocca a noi, che restiamo per qualche giorno ancora su questa terra di terra e sassi, non farci frenare dalle pesantezze del vivere e volteggiare in libertà di spirito sopra ogni pietra tombale.
Saluti chiari come gli occhi di padre Carlo
La Comunità Ebraica di Milano scrive
La Comunità Ebraica di Milano esprime cordoglio ed enorme dispiacere per la scomparsa di Sua Eminenza il Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo Emerito di Milano.
Walker Meghnagi e Daniele Nahum, rispettivamente Presidente e responsabile Rapporti Istituzionali della Comunità Ebraica di Milano, hanno dichiarato: “la morte del Cardinal Martini è per tutti gli ebrei di Milano un momento di grande tristezza e di smarrimento. Per noi era un punto di riferimento importante e un amico su cui contare. Fu protagonista del dialogo interreligioso nella nostra città e uomo di pace in Medio Oriente. Ci appelliamo al Comune di Milano affinché dedichi i Giardini della Guastalla, di fronte alla Sinagoga Maggiore di Milano, a quest’uomo nobile, carissimo a noi e alla Città tuttaâ€.
Proponiamo, in memoria del Cardinale, questo luogo altamente simbolico dato che è racchiuso tra la Sinagoga (espressione del dialogo ebraico-cristiano), l’Università Statale (cattedra dei non credenti) e la Chiesa Valdese (espressione del dialogo interconfessionale).

Di Enzo Bianchi, priore della Comunità Monastica di Bose, amico di Martini, è possibile leggere un articolo e un’intervista QUI, accanto ai saluti della Comunità .
QUI il comunicato stampa di “Noi Siamo Chiesa”, a cura di Vittorio Bellavite.
QUI l’omaggio della rivista Micromega.
QUI la cosiddetta ultima intervista, le cui parole vanno secondo me lette con estremo pudore.

(Il Cardinale a Selva di Val Gardena, nel 2009)
Ebbene, direi di no. Qualcosa di Ennio Flaiano
 Quarant’anni fa si spegneva il giornalista e scrittore Ennio Flaiano, fumatore di pipa. Ma come per Buzzati, anche per EF “giornalista e scrittore” sono sostantivi troppo poveri: ha letto e interpretato l’Italia del cosiddetto boom economico con la capacità di rimanere al di fuori degli schemi e delle consorterie.
Quarant’anni fa si spegneva il giornalista e scrittore Ennio Flaiano, fumatore di pipa. Ma come per Buzzati, anche per EF “giornalista e scrittore” sono sostantivi troppo poveri: ha letto e interpretato l’Italia del cosiddetto boom economico con la capacità di rimanere al di fuori degli schemi e delle consorterie.
Forse per questo di lui oggi si parla molto poco.
Leggendo alcune delle sue opere, la sensazione è quella di un intelletto vigile, abituato a frequentare opposizioni e incongruenze, a cogliere il limite della vita sociale e culturale del nostro paese, quasi sempre con ironia, talvolta con sarcasmo e una certa malinconia.
Quel che rimane invariata è la passione per la libertà , o meglio per la liberazione: usare le parole per indicare vie d’uscita, strettoie necessarie per mantenersi autonomi da “si dice, si fa”, siano essi prodotto del pensiero massificato o da qualche élite culturale.

Limitandomi ad un culto privato della Libertà , non sono inserito nei miei tempi. Vorrei cavarmela, insomma, e salvare la faccia, amando la Libertà : impegno che non mi costa nulla, perché l’amiamo tutti ovviamente, anche se ognuno dandole un diverso scopo e significato. Per difendere questa Libertà che io dico di amare, io dovrò invece definirla, darle un programma, rifletterla nei miei scritti, farle dei proseliti. Ebbene, direi di no. Questo mi sembrerebbe il più assurdo dei disegni perché io penso (guardi fin dove giunge il mio amore) che la Libertà è una forza vitale che può essere oscurata, mortificata, ma non soppressa e che ogni uomo, in un preciso momento della sua vita, impara veramente ad amarla; ma che pretendere di anticipare questo momento è avventato, anzi illiberale”. («Il Mondo», 6 novembre 1956)
La capacità di mettere alla berlina le ambiguità “di regime” di molti comunisti dopo i fatti di Budapest del ’56, avvicinano radicalmente EF ad Albert Camus: se il secondo comincia tardi ad essere letto come genuino filosofo, il nostro ha probabilmente cercato ogni strategia per non essere annoverato nemmeno tra i pensatori. Una costante allergia alle etichette.

Il giovane amico comunista mi saluta, mi guarda fisso, parla del tempo, di un film che vorrebbe vedere. La sua calcolata indifferenza finisce per rattristarmi. Cerco invano nei suoi occhi un’ombra di dubbio o di vergogna, non c’è niente, nemmeno il dispiacere di quest’amicizia che finisce. Sappiamo che eviteremo disalutarci, di stringerci la mano, perché io non saluto né stringo le mani agli enti, alle associazioni, alle mafiem ai dogmi, alle ragion di stato”. “Oggi leggo su «L’Unità »: «i teppisti controrivoluzionari», riferito agli insorti di Budapest. E’ un’inesattezza, professore! (EF si rivolge a Togliatti, ndr). Abbiamo già sentito un linguaggio simile, nel ’44, quando gli SS parlavano di «delinquenti badogliani», per riferirsi agli assassinati delle Fosse Ardeatine“. («Il Mondo», 20 novembre 1956)
Quanto emerge non ̬ polemica ideologica, scontro tra teoremi diversi, narrazioni collettive opposte. Piuttosto una beffarda pena, senza smarrimento Рe quindi piuttosto con disincanto -, per i cancelli che da soli, o bene accompagnati, imponiamo alla nostra mente. Piccinerie culturali.

La signora elegante (…) dice, parlando di una rivista di varietà a cui ha assistito: «Divertentissima. Mi sono p… sotto dalle risate». Il signore alla moda che l’accompagna, soggiunge garbato: «Ma cara, si faccia fare la psicanalisi delle urine». – Una società simile non ha più bisogno di niente: sa quel tanto che le basta per credersi colta e ha fiducia nella volgarità per ciò che supera i suoi interessi“. («Il Mondo», 12 novembre 1957).
Tale medesima società , la nostra, non pare esser mutata. Siamo così abituati ai velocissimi cambiamenti della tecnoscienza, da scordarci che quel noi siamo oggi in fondo è cominciato ad esistere compiutamente nel secondo dopoguerra (qualcuno direbbe anche prima del primo). Non è un tempo meraviglioso e lontano, è solo l’inizio. E così, quel che EF nota di un gruppo di ragazze, potrebbe benissimo essere detto di qualche studentessa di oggi, con l’unica differenza che la serietà da lui allora evidenziata si è trasformata oggi in una sorta di seria leggerezza, nella quale si muove la consapevolezza che la responsabilità è anch’essa un gioco:
 Danno l’impressione di aver saltato un’età e di essere già le loro stesse madri, deluse di una vita che le ha rese responsabili, rimpiangendo la felice adolescenza, che si apriva come un sipario su tutte le loro ambizioni, e su molte legittime curiosità “.
Danno l’impressione di aver saltato un’età e di essere già le loro stesse madri, deluse di una vita che le ha rese responsabili, rimpiangendo la felice adolescenza, che si apriva come un sipario su tutte le loro ambizioni, e su molte legittime curiosità “.
(«Corsera», 23 settembre 1960).
Fecondo sceneggiatore, EF comprese subito la potenzialità del mezzo visivo, la potenza dell’immagine e la sua supremazia rispetto alle altre impressioni sensibili in tutto ciò che è pubblico. Quanto egli ritrae, descrivendolo, è spesso cinematografico anche se non composto immediatamente per il cinema. Collaboratore di Fellini, EF sa che l’immagine è ambigua in duplice modo: sia perché, come segno, rimanda ad altro, come ogni linguaggio, ma anche e soprattutto perché essa riesce a nascondere questa sua capacità simbolica, proponendosi come realtà delle cose. Le cose stanno come si presentano al mio sguardo, ora? Si, ma anche no. Eppure il “ma anche no” sfugge.
 La realtà (rispetto a quanto descritto dal film ambientato in Via Veneto, La dolce vita, ndr) è migliore, in un certo senso: più agghiacciante. I caffè della strada si sono tutti rinnovati e così vistosamente che si pensa subito alla loro solitudine invernale quando – finita la bella stagione – la loro gaiezza risulterà inutilizzata e susciterà malinconia, come un luna-park sotto la pioggia. I cattivi arredatori interpretano bene la nostra sete di sfarzo, e il Caffè – vecchio baluardo della borghesia – è diventato la mostra del mobiliere. Sono spariti i divani foderati di cuoio e di velluto, gli specchi che moltiplicavano le prospettive, i camerieri sordi e venerabili e i tavoli di marmo sui quali si poteva disegnare. Adesso i caffè sembrano alcove, pagode, padiglioni di cura, tombe di famiglia“. («Europeo», 15 luglio 1962)
La realtà (rispetto a quanto descritto dal film ambientato in Via Veneto, La dolce vita, ndr) è migliore, in un certo senso: più agghiacciante. I caffè della strada si sono tutti rinnovati e così vistosamente che si pensa subito alla loro solitudine invernale quando – finita la bella stagione – la loro gaiezza risulterà inutilizzata e susciterà malinconia, come un luna-park sotto la pioggia. I cattivi arredatori interpretano bene la nostra sete di sfarzo, e il Caffè – vecchio baluardo della borghesia – è diventato la mostra del mobiliere. Sono spariti i divani foderati di cuoio e di velluto, gli specchi che moltiplicavano le prospettive, i camerieri sordi e venerabili e i tavoli di marmo sui quali si poteva disegnare. Adesso i caffè sembrano alcove, pagode, padiglioni di cura, tombe di famiglia“. («Europeo», 15 luglio 1962)
Osservare i propri simili, sapendone la similitudine, come seduto da un tavolino di caffè. Non so se EF potrebbe oggi apprezzare tale medesimo sguardo posato sulle cose a partire da un weblog come questo. Ma la realtà multiforme appariva ai suoi occhi non dissimile dal turbinio del materiale on-line dei nostri tempi: un deposito enorme, da maneggiare con cura.

Lavoro immenso che si presenta a chiunque volesse, oggi, mettere su un archivio di sciocchezze: imbarazzo nella scelta, rinvii ad altre voci, ripetizioni, cataloghi di formule che hanno fortuna. Alla fine, un lavoro sulla stupidità contemporanea diventa stupido, questo è il punto. Se ne può restare affascinati. («Corsera», 18 gennaio 1970)
Contemporaneamente a Noam Chomsky, forse addirittura prima, se pur in altro modo, EF riconobbe il fascino e la pericolosità di una società centrata sull’informazione e sulla visibilità . L’imposizione del pensiero di regime non può più essere fatta attraverso azioni coercitive, data la democrazia; altri sono i mezzi, sempre più subdoli, perché rispettosi in apparenza delle scelte individuali e invece capaci con ancor più forza di un manganello di convincere, di addormentare, di renderci piccoli e impotenti.

Il tiranno più amato è quello che punisce per una sua esclusiva ragione, la ragione che riguarda la sua propria esistenza. Chi tocca i fili del tiranno, muore. Ma con la vastità delle informazioni e quindi con la molteplicità delle emozioni che ogni giorno si scatenano in un mondo sempre più al limite dell’isterismo, le dittature hanno infine scoperto la magnanimità . Esse condannano a morte i loro nemici (il mondo freme e sussulta), e il giorno dopo li graziano. Così il mondo respira di sollievo, scodinzola di riconoscenza e rovescia altro amore sulle magnanime dittature”.
(«Corsera», 21 febbraio 1971)
Sidereus Bloggus

Lo sfondo rinnovato di comegufi è un minuscolo omaggio a Galilei.
E’ un suo disegno delle Pleiadi, tratto da un antesignano dei blog scientifici, il Sidereus Nuncius.
La foto qui sopra è scattata al Museo Galileo, già “Istituto di Storia della Scienza” di Firenze ed è opera dell’occhio prezioso di Nat (grazie!).
A proposito di astronomia, storia e scienze:
Il CIRSFIS (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia delle Scienze – Università degli Studi di Padova) organizza la Scuola estiva in Storia e Filosofia delle Scienze, dal 18 al 21 luglio 2012, a Feltre (BL). Il tema, interessante e supertrasversale, è “I nomi del tempo” Qui le info. Le iscrizioni sono chiuse, a dire il vero. Ma tra i docenti c’è un grandissimo astronomo… di casa.
Il Male: nulla di scontato
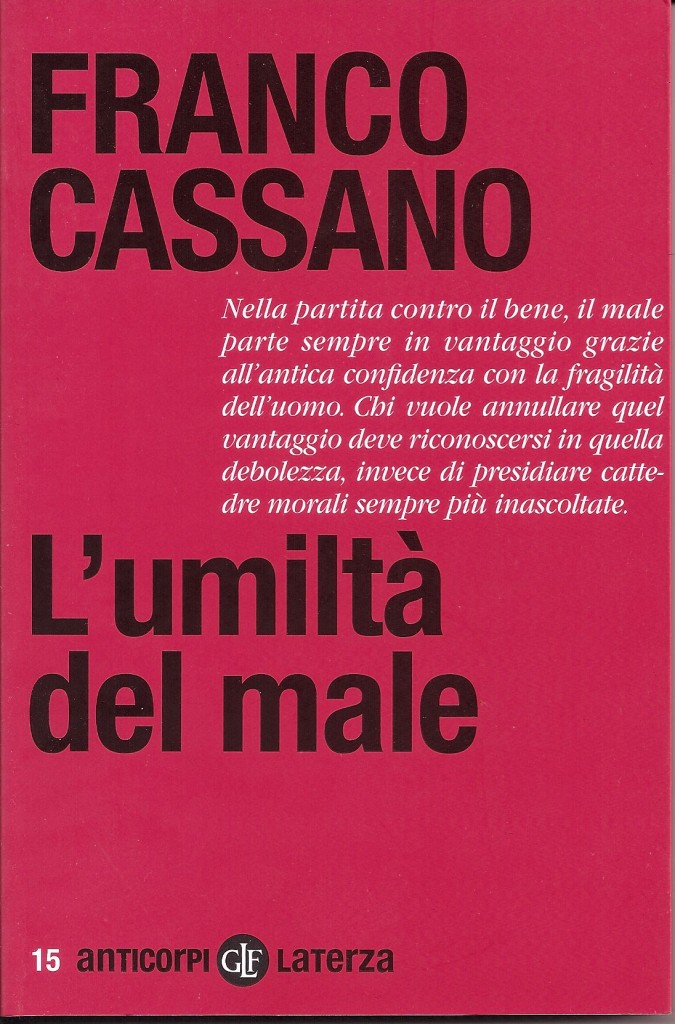
Approdo a questo denso saggio di Cassano attraverso le sollecitazioni di Pietro Barcellona, nell’ultima strenna natalizia macondina (La nostalgia di Dio nell’epoca contemporanea). Barcellona interpella il filosofo pugliese in quanto sostenitore di una posizione a lui antitetica, quella secondo cui sia possibile giustificare il Male. E’ proprio questa la scintilla che mi ha portato ad approfondire L’umiltà del male. Non è questo il luogo adatto per illustrare il dibattito tra i due punti di vista; invece mi pare interessante dar conto dell’approccio di Cassano, lasciando ai lettori il confronto.
Cassano prende le mosse da un luogo capitale della letteratura occidentale, l’incontro drammatico tra Cristo e il Grande Inquisitore ne I fratelli Karamazov. La lettura che ne ricava, tuttavia, è inedita. Se, anche per una tacita propensione di Dostoevskij stesso, siamo portati istintivamente a porci dalla parte di Gesù e del suo tentativo di porre la libertà personale quale chiave di volta del suo messaggio, Cassano invece invita a riconsiderare la posizione del vecchio prelato. Essa non sarebbe la conseguenza di una nefasta volontà di predominio sugli uomini, che, pur di avere pane e sicurezza, delegano ad altri il proprio arbitrio, quanto piuttosto la visione realistica di chi, avendo provato a seguire Cristo nella sua esigente proposta, si rende conto di come la maggioranza del genere umano debba venir condotta alla salvezza, perché lasciata a se stessa, perirebbe sotto il peso di una libertà insostenibile.
Cassano in altri termini invita a riflettere sul fatto che quanti si fanno difensori di un Bene considerato assoluto spesso, per la propria intransigenza, cadono in una sorta di miopia che dimentica come, al contrario, le potenze terrene siano ben più capaci di conoscere le debolezze umane e volgerle a proprio favore. Che vale conoscere il Bene se non si è capaci di coinvolgere in esso le persone? Il commercio con la debolezza è una forza che il malvagio conosce bene: Cassano interpella Primo Levi e la sua testimonianza su come un sistema di morte non si rivolga a individui dall’umanità corrotta, ma sia esso stesso mezzo di corruzione dell’umanità , facendo di persone normali degli aguzzini. Il perdono è dunque impossibile? Cassano non lo pensa, ma avverte con pari forza che non è un percorso semplice, perché rischia di mischiarsi all’oblio.
Nella parte finale del saggio, infine, l’autore aggiorna il dialogo evocato da Ivan Karamazov, riportando il dibattito tra due filosofi novecenteschi, Adorno e Gehlen. Anche in questo caso la prospettiva del primo risulta agli occhi dell’autore troppo esigente: l’emancipazione dell’individuo invocata dall’utopia socialista è un programma troppo ambizioso, riservato a pochi eletti, mentre i più sono destinati a rimanere invischiati nel miele della società dei consumi, esperta nel creare bisogni e desideri indotti. In essa prevale e domina il soggetto e la sua privata realizzazione. Gehlen ne è consapevole ma non riesce a gettare luce sul futuro, perché il trionfo dell’io comporta la crisi del legame sociale. E qui forse egli riesce a descrivere quel che effettivamente oggi accade. Come uscirne? Cassano non prescrive farmaci, ma rammenta la forza coesiva delle prime comunità cristiane, prima dell’avvento di una chiesa-burocrazia: un invito a coloro che si ritengono i “pochi eletti†ad uscire dal fortino della bella minoranza per incontrare debolezza e sofferenza umane, troppo umane. Un invito, aggiungo io, dal sapore eminentemente pentecostale.


