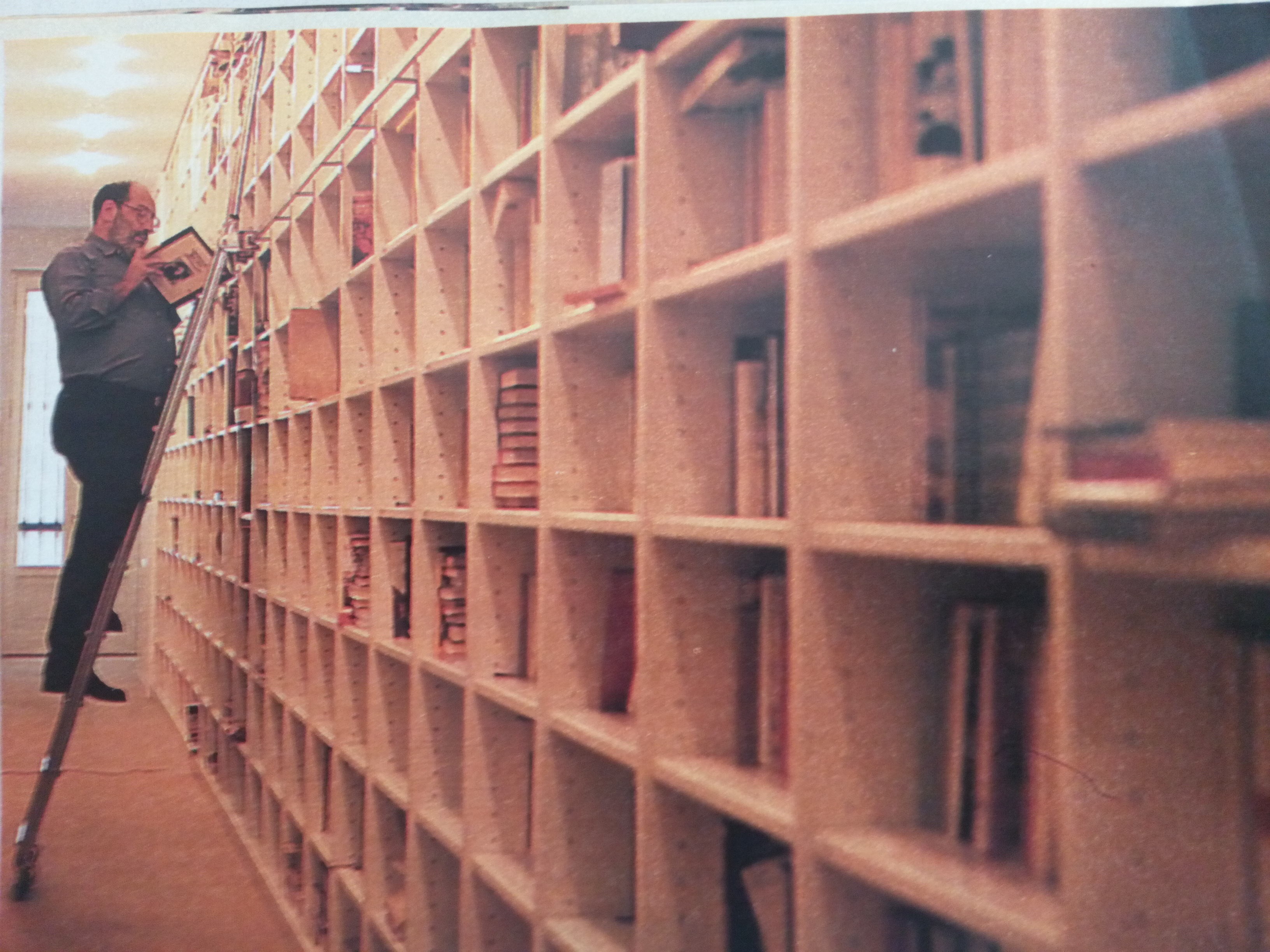In occasione della Festa del Primo Maggio 2016, pubblico le conclusioni dell’ultima edizione della Scuola del Legame Sociale – conclusasi nel luglio scorso, centrata sul tema del lavoro. Sono stato solo il redattore di uno sforzo collettivo.
“Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali.
E sono solo io – io ormai così imbastardito – a farla adesso tanto lunga. Per loro, in loro non c’era allora neppure l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là . Si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.”
(C. Peguy, 1914)
“Nell’esaltazione del «lavoro», negli instancabili discorsi sulla «benedizione del lavoro» vedo la stessa riposta intenzione che si nasconde nella lode delle azioni impersonali di comune utilità : la paura, cioè, di ogni realtà individuale. In fondo, alla vista del lavoro – e con ciò si intende sempre quella faticosa operosità che dura dal mattino alla sera – si sente oggi che il lavoro come tale costituisce la migliore polizia e tiene ciascuno a freno e riesce a impedire validamente il potenziarsi della ragione, della cupidità , del desiderio d’indipendenza. Esso logora straordinariamente una gran quantità d’energia nervosa e la sottrae al riflettere, allo scervellarsi, al sognare, al preoccuparsi, all’amare, all’odiare.â€
(F. Nietzsche, 1881)
Le citazioni di Peguy e Nietzsche non sono di oggi, ma riassumono efficacemente le contraddizioni dell’oggi e il primo tema del biennio, rappresentato da due delle domande iniziali:
• è possibile parlare di lavoro non più in termini di diritto-dovere?
• è attuale riconciliare le parole “lavoro†e “impegno�
Le altre due domande-guida sono state:
• è possibile ritrovare e rinnovare il lavoro attorno al legame sociale?
• come ritrovare un patto intergenerazionale fondativo di una nuova cultura del lavoro?
Le considerazioni di queste pagine riflettono solo in parte la ricchezza del dibattito e la complessità dei contenuti emersi, ma riteniamo siano una sostanziale e condivisa sintesi delle principali linee di riflessione.
Labor è fatica. L’etimologia suggerisce il sudore della fronte. La radice è LABH, che è usare forza per ottenere qualcosa, da RABH; il sanscrito RABBHUS è colui che imprime forza, l’artefice scultore. Da qui il boemo ROBOT, lavoro servile, lavoratore di fatica.
Il lavorare tiene insieme la fatica del travaglio, la pena, che rimane nel termine francese e porta con sé il senso della “maledizione biblicaâ€, con l’idea della robustezza, che giace nella radice sanscrita, intesa come costanza e resistenza verso un obiettivo.
Le parole nascono dalla carne e dal sangue. E la parola lavoro ha a che fare con l’azione di trasformare materiali dati dalla natura. Possiamo supporre che questa operazione avesse come primo scopo la sopravvivenza o il miglioramento della condizione di vita: contadini e artigiani.
In questo senso l’azione è, dicevano i greci, póiesis, produzione: il lavoratore ha un progetto in testa, conosce gli strumenti e, applicandoli con maestria (téchne) ottiene quel che aveva immaginato. Il greco non distingue tra la produzione di una cassetta di zucchine o la Venere di Milo, la pulizia di una strada o un’operazione a cuore aperto. In tutti i casi è azione poietica e, se fatta bene, arte.
Ciò che produco, il risultato dell’azione faticosa, possiede un valore.
Prima di misurare questo valore con quell’elemento di universale interscambio, che è il denaro, il lavoro possiede un altro tipo di valore. È quello che ci permette di trovare le differenze tra una cosa ben fatta ed una raffazzonata. Chiamiamolo valore poietico o artistico.
In esso convergono alcuni elementi
• la consapevolezza di un BISOGNO (perché mi metto all’opera? Per qual motivo intendo realizzare questa operazione?) – può essere la fame, il desiderio di costruire qualcosa che migliori una situazione umana, la manìa artistica che non ammette freni, perché è voglia di creare (un quadro, una poesia, una fotografia);
• la PERIZIA tecnica, come conoscenza dei materiali e degli strumenti, capacità di stilare un progetto realistico e un programma di realizzazione adeguato, abilità nel riconoscere il prodotto finito come “perfettoâ€, creatività ;
• la RESISTENZA, come pazienza e convivenza con la fatica, misurazione delle forze fisiche e mentali, distribuzione dei tempi e nel tempo.
Il valore artistico si misura in termini individuali, cioè di soddisfazione, di gioia per un risultato voluto; ma anche in termini sovraindividuali, perché nella costruzione dell’abilità lavorativa entra la relazione con un lavoratore esperto, che fa da maestro. Nel lavoro ben fatto stanno più persone.
Queste competenze sono finalizzate alla definizione di un’opera, ma non si limitano ad essa. Coscienza del bisogno, perizia tecnica e resistenza sono elementi di un lavoro ben fatto, ma anche di un buon lavoratore.
Riteniamo che un buon lavoratore produca un ulteriore valore, che chiamiamo valore sociale. Richard Sennett sostiene che le abilità che l’artigiano dimostra nel corso dell’opera siano le medesime che vengono agite nella democrazia:
• la capacità di localizzare i problemi, cioè di individuare con precisione dove sta il punto della questione;
• la capacità di porsi domande su di essi, di riflettere sulla loro qualità , sospendendo l’ansia di concludere per aprire uno spazio alla curiosità /creatività ;
• la capacità di aprire i problemi, cioè il darsi la possibilità di cambiare abitudini e di “pescare†soluzioni da ambiti diversi, ampliando il senso del problema originario.
Il processo lavorativo deve fare qualcosa che alla mente ben ordinata ripugna, e cioè sostare temporaneamente nel disordine: mosse false, false partenze, vicoli ciechi. [R. Sennett]
Come un buon lavoro contiene un processo aperto, allo stesso modo la democrazia è un sistema continuamente da verificare. L’essere in crisi è la condizione naturale della democrazia. Se oggi ci interroghiamo in proposito, come se fosse una novità , è solo a causa di memoria corta. (…) La democrazia non è un regime consolidato, assestato, sicuro di sé. Dove c’è consolidamento, assestamento, sicurezza del sistema di potere, lì c’è in realtà oligarchia, anche se, eventualmente, sotto mentite spoglie democratiche. [G. Zagrebelsky]
In questo senso lavoro è mestiere, come ministerium, officio, servizio. Far bene le cose che dobbiamo fare (o che vogliamo fare) produce un valore per la società , anche senza che esso sia posto da noi come obiettivo esplicito. È il contributo individuale ad un meccanismo, o anche – mutando immagine per introdurre la dimensione della finalità , del senso – ad un organismo. Ogni opera collabora, agisce e concretizza una collaborazione, a meno non si ponga esplicitamente uno scopo di separazione, di divisione.
Il lavoro, misurato nei termini di valore poietico e valore sociale, possiede elementi di gratificazione interni e fisiologici. L’elemento che li scardina e li disconosce è il denaro.
Nel momento in cui, da mezzo/strumento utile a determinati scopi, diventa fine, medium come unico ambito/linguaggio, come unico veicolo di senso tra uomo e mondo, la dinamica virtuosa del lavoro viene messa in crisi.
Non si può eliminare il denaro, qui e ora: dobbiamo prendere atto che siamo prima di tutto – prima di qualsiasi scambio – consumatori e su questa verità biologica il mercato fonda la sua pervasività . Persino adottando come fine ultimo la riduzione totale e drastica del consumo superfluo, è necessario ammettere il nostro essere di organismi viventi che consumano.
Non si può nemmeno separare il lavoro dal suo valore in termini di denaro e cioè impedire che il lavoro venga misurato con il denaro. Si tratta tuttavia di prendere atto che questo metro non riconosce, ma disconosce il lavoro stesso.
Da un lato il sistema del lavoro (chiamato anche con la pessima espressione di “mercato del lavoroâ€) produce lavoratori che non possono che avere come unico obiettivo lo stipendio, perché la loro individualità non entra in nessun modo nel processo di produzione. Qui i margini della ricerca di un lavoro ben fatto sono labili. Qui (e altrove) la precarietà del posto di lavoro e l’aleatorietà della misurazione del salario hanno come conseguenza l’aumento del conflitto sociale, perché impediscono la progettualità personale.
Dall’altro, la ricchezza è chiaramente spostata nelle mani di chi si pone come obbiettivo la moltiplicazione del denaro (la speculazione), e il suo correlato principale, il potere. Questo è il piano di senso che con maggior forza richiama la giustizia, intesa come equa distribuzione della ricchezza (è il 99 contro 1).
Questo a grandissime linee spiega l’alienazione, che ormai riguarda anche il terziario e non solo la manifattura; spiega la potenza dell’economia finanziaria e dei suoi prodotti velenosi; spiega l’ambiguità di chi lavora eludendo il fisco (e talvolta ciò sembra accadere a prescindere dall’ingiustizia di un sistema di tassazione); spiega infine la crisi del cosiddetto Terzo Settore e perfino del cosiddetto volontariato: in essi si è forse rinunciato all’accumulazione del denaro, ma non a quella del potere. Denaro e potere, inutile dirlo forse, hanno da sempre spiegato la evidente corruzione dell’azione politica e perfino istituzionale.
Il denaro adottato come obiettivo impone al lavoro due elementi cancerogeni: logica della competizione e logica della prestazione. Tutto questo si traduce in termini di riduzione dei tempi, aggressività , dispersione degli spazi (non-luoghi) e assottigliamento delle relazioni, destinate a divenire funzionali, anonime e a breve termine (dato il potenziale frequente cambio di luogo di lavoro, che non è altro che l’ultima espressione del congelamento dei rapporti sociali). Quello che viene messo in discussione è l’obiettivo – che è un bisogno strutturale dell’uomo – di darsi una biografia coerente.
Ora, viviamo in tempi complessi. Prima ancora che sul piano della riflessione (filosofica, sociologica, politica) questo si manifesta nelle esistenze reali: un ottimo falegname non paga le tasse, perché sono eccessive (e lo sono); un progetto relativo alla difesa contadina della biodiversità viene ospitato da Expo, supportato dalle multinazionali; la misurazione delle quote di ingresso di immigrati, e la relativa politica di gestione degli sbarchi, avviene sulla base del bisogno di manodopera; insegnanti appassionati spiegano il diritto al lavoro ad adolescenti che, sottoposti ad un sistema di formazione in continua espansione (in termini di anni di vita), non sanno se potranno trovarne; la potenzialità di un curriculum costruito su multicompetenze acquisite si confonde con l’incertezza dei termini contrattuali (precarietà e flessibilità si mescolano); genitori che non possono che parlare solo il linguaggio del “posto fisso†contribuiscono al mutuo del figlio precario/flessibile; la cooperativa sociale e i suoi dirigenti sono al centro si un sistema di corruzione legato alla distribuzione dei fondi destinati al sociale…
Tutto questo accade, ripensando al motivo fondante di questa Scuola, mentre il Legame Sociale viene vissuto non solo, fisiologicamente, nel suo essere ponte (bridging), ma sempre più nel suo essere chiusura (bonding), nel ribadire identità forti, per lo più create ad hoc. Sono identità religiose – per cui il Testo Sacro si fa legislazione civile; politiche – per cui la difesa del (mio) gruppo si fa bene collettivo (ivi compreso il linguaggio lamentoso delle minoranze resistenziali, che continuamente si rinnovano); sono spesso piccole identità di interesse, che coinvolgono chiunque, compresi coloro che si fanno o dicono attori di cambiamento.
Questa dicotomia ha infatti a che fare con il linguaggio del cambiamento. Ogni prospettiva rivoluzionaria, nel senso ideologico (novecentesco) del termine appare come una chiusura: non è solo impraticabile, ma uccide il dialogo sul cambiamento. Un prospettiva rivoluzionaria implica il disconoscimento del buono che già accade, perché non riconosciuto, o sempre riconducibile alle premesse da abolire. Eppure le premesse rivoluzionarie avevano l’ardire di concepire una soluzione collettiva.
Alla rivoluzione va affiancata e sovrapposta la RIVOLTA, intesa (alla Camus) come atto singolo che metta in luce (rifletta) una disuguaglianza, o pratichi un’azione di abbattimento di una disuguaglianza sostanziale.
Partendo dalla Scuola del Legame Sociale, non possiamo evitare di affermare che, chi come noi abbia il tempo di parlare di cambiamento, può godere di una, per quanto per molti precaria, soddisfazione dei bisogni primari. In altri termini, il cambiamento che desideriamo vedere e agire riguarda sì noi, ma ancor più dovrebbe riguardare chi non ha la forza di poterlo pensare. Qui andrebbe ripresa la categoria biblica dei “poveriâ€.
La Rivolta per eccellenza – la Rivolta che può riguardarci al termine del biennio – è quella che sta alla base del lavoro: la consapevolezza dei propri bisogni. L’azione di cambiamento appare praticabile quindi in primo luogo sul piano dell’educazione individuale, del confronto tra persona e persona, nei termini essenziali di una ecologia del bisogno.
Discorso e azione sono le modalità con cui gli esseri umani appaiono gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini. Questo apparire, in quanto è distinto dalla mera esistenza corporea, si fonda sull’iniziativa, un’iniziativa da cui nessun essere umano può astenersi senza perdere la sua umanità . [H. Arendt]
La domanda: “di che cosa ho davvero bisogno?†(che cosa posso – devo – sono costretto a consumare?) appare la prima iniziativa urgente.
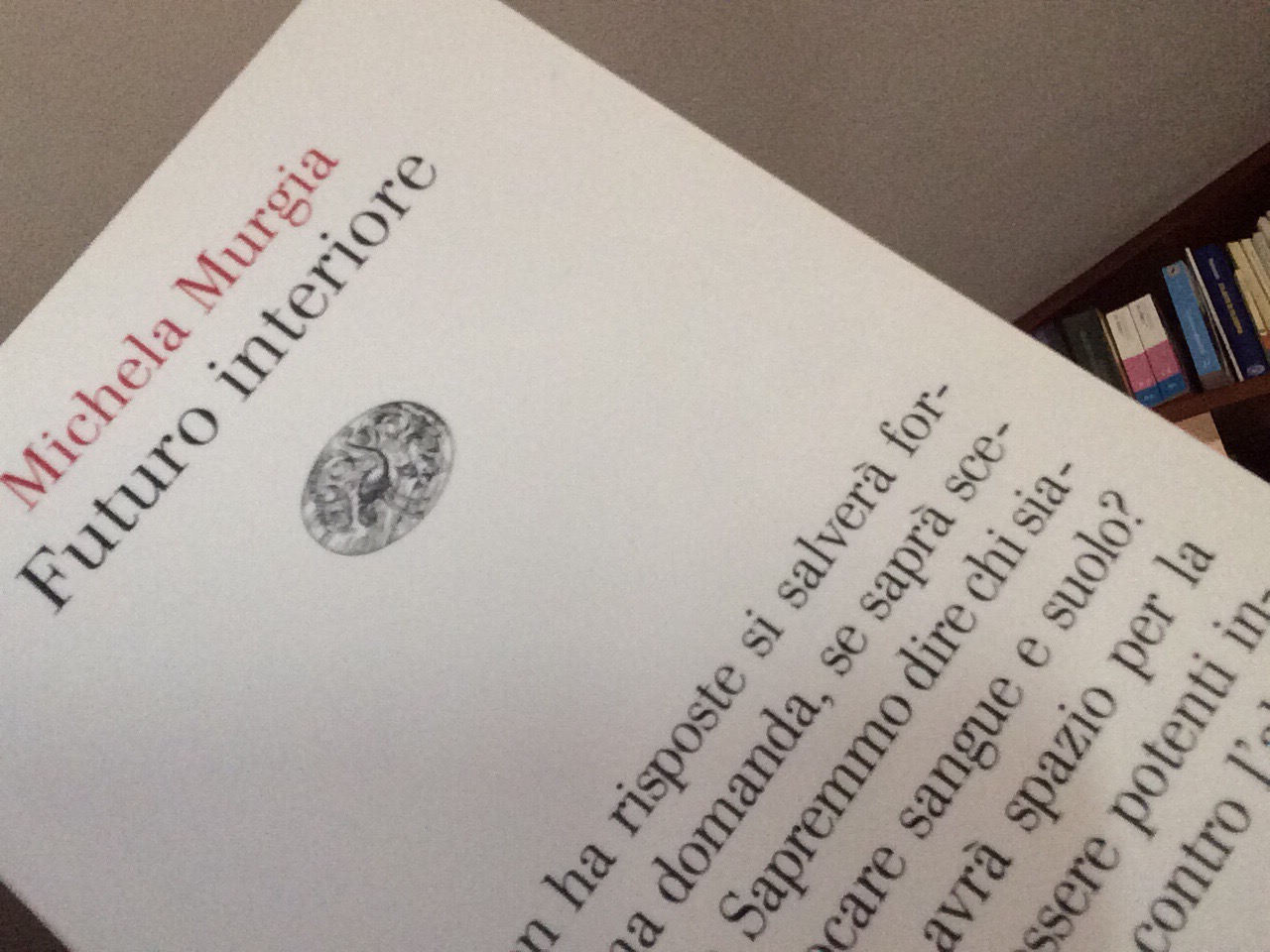



 Il divertissement di Christian Raimo (
Il divertissement di Christian Raimo ( ento sia addebitabile agli studenti.
ento sia addebitabile agli studenti.